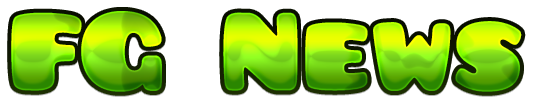È un crepuscolo qualsiasi nella zona della stazione di Monza, ma il sipario sta per alzarsi su un dramma in miniatura, una scena fugace che condensa l’eterna lotta tra il rigore della dottrina e la cruda, disarmante realtà dell’esistenza umana. Il protagonista è l’uomo comune, l’eroe stanco dei nostri tempi: un operaio. Dopo dieci ore passate a piegare il corpo al volere di un cronometro e altre due prigioniero nel limbo della tangenziale , cerca solo il conforto minimo, la tregua di un bicchiere di birra nel rifugio confortevole del bar. È il rito di purificazione laico dopo la fatica del giorno.
Ma la vita, e soprattutto la morale, non concede tregue.
Il Crocifisso Come Machete: L’Inquisizione sul Marciapiede
Proprio mentre l’operaio varca la soglia – quel confine invisibile tra la strada e il santuario del bancone – l’ombra della condanna gli si para davanti. Una Suora. Non una figura eterea, ma un’immagine di severità inappellabile: abito blu rigido, sguardo da inquisizione, e un crocifisso talmente grande che sembra “un machete” . Un’icona di giudizio calata improvvisamente sulla scena di un bisogno disperato.
La sua voce non è un sussurro di conforto, ma una tromba di accusa: “Giovanotto, pensa ai tuoi genitori in paradiso. Il demonio è nel bicchiere. È lì che ti aspetta col prosecco secco” . In queste poche parole si racchiude la millenaria tradizione di condanna del piacere, del corpo e di ogni forma di sollievo terreno, elevando un semplice bicchiere a strumento del male assoluto. Per l’operaio, stanco, affamato e desideroso solo di rilassarsi, è un affronto, una negazione della sua stessa umanità dopo un’estenuante giornata.

La Domanda che Infrange la Morale
L’operaio, pur allibito, trova la forza di rispondere con la più semplice e devastante delle domande, quella che smantella ogni castello morale costruito sulla teoria: “Senta sorella, ma lei ha mai bevuto?” .
È il momento di svolta. La domanda non è un’offesa, ma una richiesta di autenticità. Come può un individuo giudicare la consolazione di un bicchiere senza aver mai provato il sapore di ciò che condanna? Il silenzio che segue è gravido di significato. La Suora, rigida fino a quel momento, è costretta a “abbassare lo sguardo” . La confessione che ne deriva è un’ammissione di fallimento della dottrina di fronte all’esperienza: “a dir la verità, no. Forse dovrei provare prima di giudicare”. In quel momento, l’Operaio, l’uomo del popolo, diventa il maestro, e la Suora, l’autorità morale, l’allieva che deve confrontarsi con il mondo reale.
Il Segreto della Tazza e il Trionfo dell’Ipocrisia
Avviene poi l’assurdo, il passaggio dalla critica sociale alla commedia nera. Riconosciuta la validità dell’esperienza, la Suora non solo acconsente, ma esprime una preferenza specifica: “ma il gin piace molto” . La rigidità morale non è abbattuta, ma semplicemente bypassata, negoziata con un dettaglio grottesco.
E poi l’ordine cruciale, la clausola che sigilla il patto con l’ombra: “Va bene un gin, ma per favore me lo porti in una tazza. Non voglio che mi vedano bere” .
Questo gesto è l’essenza dell’ipocrisia istituzionale: la proibizione resta valida a livello pubblico, ma è annullata in privato, purché si mantenga l’apparenza. La tazza diventa un simbolo potentissimo: il tentativo disperato di nascondere la fragilità umana, il desiderio e il vizio dietro il velo di una rispettabilità. Il gin, un liquore noto per la sua potenza e il suo sapore deciso, è l’antitesi di un pasto frugale o di una bevanda analcolica, suggerendo una ricerca di sollievo intensa, forse violenta, mascherata da un innocuo tè.
La Rivelazione del Bancone: Il Ciclo della Caduta
L’operaio entra nel bar “ridendo tra sé” , convinto di essere stato l’artefice di un piccolo, isolato trionfo della realtà sulla finzione. Avvicinandosi al bancone, ordina: “Ciao Franco, mi fai una birra e un doppio gin tazza” .
La reazione del barista, Franco, è il vero colpo di scena. Non un’espressione di sorpresa, ma uno sguardo “storto” e un sospiro rassegnato. La sua risposta non è una domanda, ma una sentenza: “È tornata quella suora del cavolo, se…”.
In quel momento, l’episodio isolato si dissolve. La “tazza” non è un’invenzione del momento, ma un codice, un modus operandi ben noto al barista, il custode non ufficiale dei segreti della comunità. La Suora, l’autorità morale che si ergeva come bastione contro il vizio, non è una vittima di una debolezza estemporanea, ma una cliente abituale, il cui desiderio di gin è così frequente da aver generato un ordine personalizzato e irridente (“quella suora del cavolo”).
La rivelazione di Franco svela un ciclo di caduta e apparenza: la Suora esce dal bar per predicare l’astinenza, ma il suo vero santuario è il bancone, e il suo sacramento un doppio gin, bevuto di nascosto. Il barista, cinico e saggio, è l’unico a vedere il teatro quotidiano della repressione e del vizio nascosto.
Una Critica Sociale Profonda in un Sorriso Amaro
La barzelletta, nella sua semplicità, si eleva dunque a potente critica sociale e culturale. In primo luogo, essa mette in discussione l’autorità morale che non deriva dall’esperienza. Allevi l’assunto che si possa giudicare ciò che non si conosce, mostrando come l’ignoranza diventi il fondamento di un fanatismo rigido e, in ultima analisi, insostenibile.
In secondo luogo, è una riflessione sull’alienazione del lavoro e sul bisogno di sollievo. L’operaio, simbolo della fatica fisica e mentale, cerca un momento di oblio o piacere. La Suora, forse alienata dal suo stesso ruolo e dalla repressione emotiva che comporta, cerca un’evasione simile. Entrambi sono in cerca di un “gin” – un antidoto – per la durezza del loro mondo, ma uno lo fa alla luce del sole e l’altra nell’ombra di una tazza.
Infine, la barzelletta è un commento sull’ipocrisia delle istituzioni. La Chiesa, o più in generale ogni sistema di valori rigido, è qui rappresentata come un’entità che richiede la purezza pubblica, tollerando silenziosamente la trasgressione privata. Il “doppio gin tazza” è la perfetta metafora di questo compromesso: la forma (la tazza) salva la faccia, mentre la sostanza (il gin) salva l’anima dalla disperazione.
La risata finale che accompagna questa storia è, pertanto, una risata amara. Non è solo divertimento, ma il riconoscimento della complessa, contraddittoria e profondamente umana realtà: spesso, chi predica la purezza è il primo a cercare conforto nel vizio, e il vero dramma si consuma non sui grandi palcoscenici della morale, ma nei piccoli, inconfessabili segreti sussurrati a un barista stanco al calar della sera.